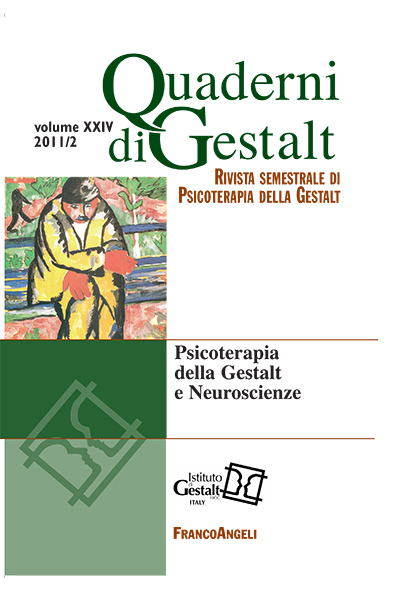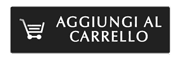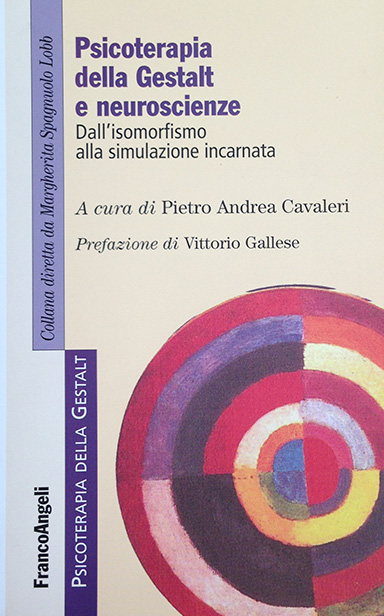Fin dalle sue origini, la psicoterapia della Gestalt asserisce che l’organismo e l’ambiente, l’individuo e il suo contesto, contribuiscono a co- creare un campo condiviso. Il campo di Perls è una realtà “vissuta” nella carne, sempre sperimentata nel qui e ora del confine di contatto, attraverso la struttura scheletrico-muscolare del corpo, attraverso la pelle e i suoi incavi, gli organi di senso. Le scoperte di Rizzolatti, di Gallese (2007) e dei loro colleghi, affermando l’esistenza di una “base neurale condivisa” nelle relazioni intersoggettive, offrono con tutta evidenza numerosi elementi di sostegno all’accezione di campo espressa da Perls e dalla psicoterapia della Gestalt.
Ciò che, da questo primo confronto, sembra accomunare le evidenze neuroscientifiche con le intuizioni dell’approccio gestaltico è soprattutto il primato dell’emozione sulla cognizione, del preverbale sul verbale, dell’implicito sull’esplicito, dell’indicibile sul dicibile, della comprensione sulla spiegazione e, dunque, della realtà “sperimentata” dal corpo in azione su quella “rappresentata” dalle funzioni cerebrali più complesse ed evolute.
L’essere umano, che emerge dalle descrizioni operate da buona parte dei neuroscienziati – ne è un esempio fra tanti Vittorio Gallese (2006) – non risulta, come paventato da qualcuno, deformato da antiche e rinate tendenze riduzionistiche (cfr. Noe, 2010). Esso, invece, appare in tutta la sua complessità e viene compiutamente colto anche nella dimensione fenomenologica della sua esistenza, del suo esserci.
Corpo e mente, natura e cultura non risultano contrapposti in una concezione dualistica dell’umano, ma concorrono a disegnare di esso una visione che non esiteremmo a definire in qualche modo “olistica”, così come accade nella tradizione più radicata e consolidata dell’approccio gestaltico. Nell’ambito della ricerca scientifica una tale concezione olistica, già a partire dagli anni ’20, aveva trovato un suo autorevole sostenitore in una delle “radici” più vitali della psicoterapia della Gestalt, il neurologo Kurt Goldstein (2010), nel cui laboratorio a Francoforte Perls aveva lavorato e aveva incontrato la moglie Laura.
Damasio, smascherando “l’errore di Cartesio”, restituisce unità all’essere umano e fornisce un indiscutibile fondamento neuroscientifico ad una visione “olistica” di esso. Infatti, per Damasio, come per Perls, “la mente-è- nel-corpo”, e interagisce di continuo con l’ambiente, scaturendo incessantemente dall’esperienza percettiva. Essa è in vario modo una “realtà” di confine, è in larga parte espressione di un sofisticato e complesso processo di integrazione e non di rigida separazione, così come in una certa misura aveva già intuito Spinoza (cfr. Changeux-Ricoeur, 1999).
Con quasi mezzo secolo di anticipo sulle evidenze scientifiche raccolte dalla ricerca neuroscientifica – e in relativa solitudine – Perls e i fondatori della psicoterapia della Gestalt intuiscono come il confine di contatto sia il “luogo” dove l’esperienza percettiva e l’azione, il movimento, danno origine al pensiero; il “luogo” dove si generano i primi processi regolativi e l’io inizia a conoscere, a distinguere ciò che gli “appartiene” da ciò che gli è “e- straneo”; dove “funziona” il sé, dove cioè si configura la consapevolezza di un sé capace di integrare “interno” ed “esterno”, organismo ed ambiente; dove il sé inizia ad “orientarsi” e ad “intenzionarsi” nel campo, di cui è intensa e sempre nuova espressione (cfr. Perls et al., 1997).
Siamo dunque ben lieti di presentare ai lettori dei Quaderni di Gestalt questo numero dedicato al dialogo con le neuroscienze. Gran parte dei contributi sono tratti dai due convegni suddetti, ma altri attingono a prospettive caute se non critiche su questo dialogo, e consentono al lettore di avere una visione più ampia del panorama attuale in merito.
Apre il numero un dialogo tra Vittorio Gallese e Margherita Spagnuolo Lobb, dal titolo Il now-for-next tra neuroscienze e psicoterapia della Gestalt, che prende spunto dal recente libro di Spagnuolo Lobb per sviluppare uno scambio su temi di interfaccia tra la clinica e la ricerca.
La sezione Dialoghi segue con un’intervista di Pietro Cavaleri a Vittorio Gallese, Afferrare l’altro, sull’esperienza percettiva come movimento verso l’altro.
Chiude la sezione un’intervista di Mariano Pizzimenti a Marco Neppi Modona, dal titolo Dall’hic et nunc del cervello alla bellezza della rosa, sulla difficoltà dell’incontro tra scienze biomediche e scienze umane, che sottoli- nea convergenze e nodi problematici di cui dobbiamo tutti tener conto.
La sezione Relazioni apre con un articolo storico di Eagle e Wakefield su La psicologia della Gestalt e la scoperta dei neuroni specchio, apparso originariamente nella rivista tedesca Gestalt Theory. Questo lavoro mette in evidenza come il concetto di isomorfismo gestaltico abbia in realtà anticipato la scoperta dei neuroni specchio.
Giuseppe Spatafora, un filologo, ci parla di La fisiologia delle passioni in Omero, un coinvolgente contributo sulle emozioni incarnate nell’epoca omerica.
Segue un articolo di Valeria Rubino su Empatia incarnata tra psicoterapia della Gestalt e neuroscienze, che rivisita il concetto gestaltico di empatia alla luce delle scoperte delle neuroscienze.
Pietro Cavaleri ci parla de I luoghi della mente e la bellezza, con un excursus dei concetti di “confine di contatto” e di “mente” sia in psicoterapia della Gestalt che nelle neuroscienze.
In chiusura di sezione, Gina Merlo ci propone il suo contributo dal titolo
Dal triadico al quadriadico: il sé gemellare e riflessioni sulla fratria in psicoterapia della Gestalt, aprendo un varco importante per le riflessioni e le ricerche sul sé gemellare.
Nella sezione La Gestalt in Azione, pubblichiamo la trascrizione della seduta che Spagnuolo Lobb ha offerto durante uno dei due convegni, seguita dal commento di Vittorio Gallese. Titolo dell’articolo è: Dall’enteroception al sostegno dell’intenzionalità di contatto. Lo sguardo del neuro-scienziato sul lavoro gestaltico dal vivo ci sorprende piacevolmente, per la spontaneità e la concretezza delle sue osservazioni, e per gli agganci a situazioni sperimentali che offre.
Nella sezione Studi e Modelli Applicativi, il ricercatore dell’Istituto Stella Maris di Pisa, Antonio Narzisi, ci presenta, assieme al suo Direttore, Filippo Muratori, un lavoro sul riconoscimento delle emozioni nei bambini autistici, dal titolo Empatia e Teoria della Mente nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo: le persone con autismo possono riconoscere le emozioni?
Alessandro Vizzi, poi, ci presenta una ricerca sull’empatia che l’osservatore di un’opera d’arte sviluppa verso il pittore: Sull’esperienza estetica. Il sistema dei neuroni specchio e la comprensione del gesto pittorico.
Silvia Tinaglia ci racconta il terzo congresso della Società Italiana Psicoterapia Gestalt, svoltosi a Palermo dal 9 all’11 dicembre 2011, in cui circa 500 psicoterapeuti della Gestalt provenienti da tutto il Paese hanno celebrato l’appartenenza alla comunità gestaltica italiana, attorno al tema Il dolore e la bellezza: Dalla psicopatologia all’estetica del contatto.
In questo numero presentiamo due libri importanti per la nostra comunità scientifica. Henry (Zvi) Lothane, psicoanalista, recensisce il libro storico di Bernd Bocian, recentemente uscito in Italia nella nostra Collana di Psicoterapia della Gestalt, Fritz Perls a Berlino – 1893-1933. Espressionismo, psicoanalisi, ebraismo.
Antonio Ferrara, direttore dell’Istituto di Gestalt e Analisi Transazionale di Napoli, recensisce il libro di F. Varela, F. Bertossa e R. Ferrari, V. Gallese, L. Boella, dal titolo Neurofenomenologia – Le scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente.
Nelle Commemorazioni, Bernd Bocian ci presenta un ricordo di Paul Goodman, nel centenario della sua nascita, iniziando così una collaborazione con la Rivista, che dal prossimo numero si concretizzerà nella rubrica Storia e identità: pensieri dallo sfondo.
Chiude il numero un ricordo di Serge Ginger, scritto da Gianni Francesetti. All’amico e collega, scomparso poco prima del congresso della SIPG, che tanto ci ha insegnato sulla generosità e la passione con cui si può essere psicoterapeuti della Gestalt, va il nostro ringraziamento, nella certezza che la sua opera sarà terra fertile per il futuro del nostro approccio.